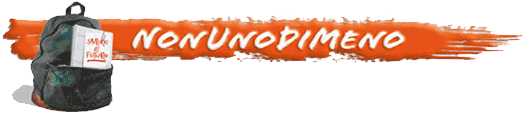Le sorelle Bucci raccontano l’Olocausto : "Germania ha fatto i conti col suo passato, tocca all’Italia"
Tatiana e Andra Bucci sono la Storia. Come lo sono Sami Modiano, Piero Terracina e pochissimi altri, in Italia si contano ormai nelle dita di una mano. Sopravvissute all’Olocausto e testimoni dirette che ancora hanno l’energia di raccontare. Due sorelle di padre cattolico e mamma ebrea, internate a 4 e 6 anni insieme alla mamma e altri parenti, il 4 aprile del ’44 ad Auschwitz, scambiate per gemelle e dunque finite nei Kinderblock del dottor Morte, Mengele.
Miracolosamente scampate all’eccidio. Il perchè si salvarono è tema ancora oggetto di ricerche e studi, il dopo invece è stato tutto diligentemente ricostruito in una lunga triangolazione di luoghi diversi : da Auschwitz, salvate dall’Armata Rossa, a Praga in un centro di raccolta di orfani dell’Olocausto, poi in Inghilterra a Lindfield, in un altro centro di aiuto per bambini ebrei, poi accolte in una famiglia inglese e, alla fine del ’46, l’incontro con i genitori anche loro scampati alla stazione Tiburtina. Circondate da decine di altri padri e madri che mostravano loro le foto dei propri figli, "li avete visti ? sapete dove sono ?", e loro, frastornate che scuotevano la testa. Neanche parlavano più l’italiano.
Andra e Tatiana sono ospiti a RepIdee, ancora insieme, due signore ancora giovanili, anche sbarazzine, una vive a Padova, l’altra a Bruxelles, forza pura di testimonianza per le giovani generazioni che vogliono essere più consapevoli, più avvertite che il Male è esistito e che, magari sotto altre fattezze e in nome di qualcosa di altro, potrebbe tornare. E con Tatiana che dice : "Fino a qualche anno fa avevo il terrore di sentir parlare tedesco, poi però un loro giornalista ci ha aiutato a far riemergere la nostra storia e quella, più tragica, di nostro cugino Sergio e mi ha fatto capire quanto la Germania avesse fatto i conti col suo passato, quanto i tedeschi di oggi siano consapevoli della loro passata bestialità. Non altrettanto mi sembra che abbiano fatto gli italiani".
Entrano nella sala del Podestà a Palazzo Enzo con la sala piena fino all’ultimo strapuntino e vengono accolte come meritano. Tutti in piedi ad applaudire, un’acclamazione che coinvolge e commuove. Loro si scherniscono, quasi si ritraggono per pudore, non vogliono apparire per troppo protagonismo. La storia che si apprestano a raccontare è atroce e, insieme, fortunata. "Per anni abbiamo taciuto, avevamo tatuato nel braccio il numero del campo, 876543, e da ragazze, negli anni ’50, ancora in autobus i ragazzi ci fermavano per chiedere se quello fosse il nostro numero di telefono. Noi rispondevamo di sì"
Fanno parte di quella manciata di bambini, una cinquantina di tutti i paesi europei, che riuscirono a sopravvivere per una roulette della vita che dopo tanto dolore le ha dato un briciolo di risarcimento : i campi nazisti di bambini ne avevano sterminati tra i 200 e i 250mila. Tatiana e Andra, insieme al cuginetto Sergio, la mamma e la nonna, furono prelevate dai tedeschi a Fiume il 28 marzo del ’44. Le tradì una soffiata di un fascista italiano. Per due giorni furono rinchiuse alla Risiera di San Sabba, poi arrivarono nel lager col treno merci. Nove mesi nell’inferno poi la liberazione delle truppe sovietiche.
Microfono a loro : "I tedeschi arrivarono di sera, a fine marzo del ’44, ricordo che urlavano e che avevano lunghi cappotti scuri. Nostra madre ci vestì per benino, col cappotto, con i cappellini di lana, che forse ci salvarono dal gelo della baracca. Con abiti uguali, sembravamo due gemelline" comincia Tatiana. Erano 74 anni fa. Da Fiume a Trieste e poi caricate sui vagoni della morte. "Un viaggio lungo, difficile. Non potevamo stare in piedi ma almeno avevamo con noi nostra madre e nostra nonna. Papà no, era prigioniero in Sud Africa, non lo vedevamo da anni ma mamma tutte le sere, mentre eravamo nascoste, ci faceva vedere la sua foto per salutarlo, per essere certa che un giorno quando (se) l’avessimo rincontrato l’avremmo riconosciuto, sapevamo che aspetto avesse. Per nonna tutto questo doveva essere molto penoso, ricordo che c’era un solo secchio per i bisogni corporali, no, non andavamo certamente verso un normale luogo dove i grandi dovevano lavorare, così come avevamo sentito dire". Pausa. Tutti in platea tacciono. In silenzio anche il direttore Mario Calabresi affiancato da Umberto Gentiloni, autore del libro "Bombardare Auschwitz". "Ora parla Andra, facciamo sempre così, almeno l’altra ha tempo di respirare dopo aver rivissuto l’incubo".
"Ricordo quando il treno si fermò, mamma e nonna le misero a destra, noi dall’altra parte. Ricordo i filari di alberi, ci tatuarono. Io ho il numero 76483, da quel momento noi non avevamo più un nome. Io, mia sorella e nostro cugino finimmo nella baracca dei bambini. Sembra assurdo ma non mi ricordo di aver mai pianto, di aver cercato mamma, di essermi mai lavata o di essere mai andata in bagno. Facevo sempre la pipì nel mio giaciglio, la notte, io che a casa non la facevo più da tempo. E mi ricordo bene altre cose : un camino molto alto in lontananza che fumava sempre e qualche volta c’erano fiamme, un gran freddo, la neve, la terra bagnata e quando camminavo tenevo i piedi rattrappiti per non perdere le scarpe nel fango. Stranamente però era come se ci fossimo abituate subito alla nuova vita, nel bene e nel male". Ora le sorelle si prendono un’altra pausa. La parola va a Umberto Gentiloni : " Ad Auschwitz circa l’80, 85% per cento delle persone che arrivano sui convogli vengono subito eliminate. La separazione dei nuclei familiari è straziante, crea confusione, destabilizza, tant’è che i nazisti poi decisero di compierla nei luoghi di partenza, non al momento dell’arrivo".
Ancora Tatiana : "Mamma ogni tanto ci veniva a trovare, e ci ripeteva sempre. ’ricordate i vostri nomi, ripeteteli tutte le sere’ e forse anche questo ci salvò perchè alla fine, quando finimmo nei diversi centri profughi dopo l’entrata delle truppe sovietiche, eravamo tra i pochissimi bambini che ricordavano le nostre generalità. E fu più facile ricongiurgerci con le nostre famiglie. Sì, anche mamma si salvò e papà uscì dalla prigionia, ma ci vollero ancora due anni prima che ci potessimo ritrovare".
E la loro storia è ancora lunga, con i ricordi sulla capoblocco che si affezionò a loro, con la perdita del cugino che rispose sì quando un tedesco col camice bianco, che si faceva chiamare dottore, chiese se qualcuno di loro volesse rivedere la mamma, e fece un passo avanti ma era la trappola più feroce : finì ucciso, dopo atroci esperimenti, in un sottoscala di una scuola d’Amburgo insieme ad altri 20 bambini trovati morti il 20 aprile del ’45, appena finita la guerra, appesi ai ganci di un macellaio. Poi la felicità dell’incontro con i genitori a Roma, alla stazione Tiburtina, ritrovati grazie a quella foto che la mamma faceva loro vedere ogni sera prima degli anni dell’incubo, e spedita nella casa della famiglia inglese che li aveva ospitati come profughi. E i lunghissimi anni del silenzio, fino alla fine degli anni ’70, e poi diventate instancabili ospiti nelle scuole, tra gli studenti, ovunque valga la pena di diffondere una testimonianza diretta della Memoria. "Ma ad Auschwitz ci siamo tornate solo 60 anni dopo".
Le signore ora tacciono, il direttore Calabresi le ringrazia per il loro meraviglioso impegno di testimoni, "pilastri di Storia in questa Europa di pericolosi revisionismi". "Perchè lo facciamo ? Per i nostri nipoti, che sono la vita che continua". E via alla proiezione di un cartone animato dedicato alla loro epopea : "La stella di Andra e Tatiana" realizzato da tre giovani donne - l’ideatrice Alessandra Viola, la regista Rosalba Vitellaro e l’illustratrice e direttore artistica Annalisa Corsi - che si sono dedicate a far riemergere e divulgare la vita speciale di due grandi donne. Andrà presto sulla Rai, sarà proiettato nelle scuole e non scivolerà via presto.
Un articolo di Simona Casalini - LaRepubblica 08 06 2018
![]() per saperne di più : il reportage di Mario Calabresi qui : Noi, le ultime bambine
per saperne di più : il reportage di Mario Calabresi qui : Noi, le ultime bambine