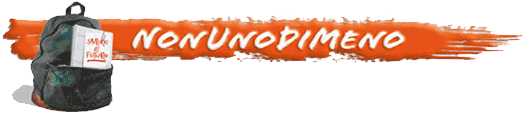Il futuro è nelle periferie, ma è necessario rendere multifunzionali i quartieri perché la città divenga un luogo di appartenenza aperto alla sorpresa.
INTERVISTA A RENZO PIANO di Franco Lorenzoni
Mi fa piacere ripubblicare questa settimana, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova,P questa intervista a Renzo Piano fatta per Cooperazione Educativa, la rivista del MCE.
Incontro Renzo Piano nella stanza numero 24 del 1° piano di Palazzo Giustiniani, che gli è stata assegnata quando è stato nominato senatore a vita dal presidente Napolitano. Lui l’ha completamente trasformata, coprendo le alte pareti con grandi compensati, ora colmi di progetti. Al centro tutto lo spazio è occupato da un grande tavolo circolare di compensato, dove si riunisce e lavora il gruppo di giovani architetti selezionati ogni anno a far parte del gruppo G124, che prende il nome da questa stanza del palazzo ed è impegnato in progetti di ricucitura delle periferie. E’ a loro che Renzo Piano devolve l’intero compenso che riceve come Senatore.
Oltre 2700 anni fa un gruppo di navigatori migranti, provenienti dalla Grecia, sbarcarono in Sicilia e fondarono Mégara Iblea vicino a Selinunte. Nel progettare la nuova città fecero una scelta rivoluzionaria che ancora adesso ci stupisce. Scelsero infatti di non edificare al centro la costruzione più visibile e notevole da dedicare al culto di esseri superiori o che rappresentasse in qualche forma il potere. Nel luogo centrale di quella che chiamavano polis, decisero di non costruire nulla, e quello spazio pubblico vuoto, posto al centro della città, è probabilmente il più antico antenato della democrazia, perché era uno spazio libero dedicato all’incontro, agli scambi, alle parole. Jean-Pierre Vernant racconta questa storia in una conferenza rivolta a un gruppo di architetti, sottolineando che “a un certo punto, nella storia dell’umanità, l’elemento politico è venuto a coincidere con il carattere intellettuale ed estetico del lavoro dell’architetto”.
Tu che hai progettato molti edifici che sono divenuti luoghi di incontro e di scambio, cosa pensi del rapporto tra architettura e politica ?
Abbiamo tanti modi di chiamare le piazze quanti ne hanno gli eschimesi per chiamare il ghiaccio perché, se vuoi fare in modo che la gente si incontri, devi sempre cominciare da una piazza, da un largo, da un campiello, chiamalo come vuoi. Per me le cose non nascono mai pensando ai pieni, ma ai vuoti. E i vuoti delle città sono le strade, i fiumi, i lungo fiumi e, naturalmente, le piazze, che sono il miracolo, l’elemento focale, l’agorà. Quando parli di politica e di architettura pensi subito alla polis e al periodo in cui la polis e l’agorà coincidevano. C’è il famoso giuramento dei neoeletti ateniesi : vi promettiamo di restituire la città più bella di come ce l’avete consegnata. Il giuramento lo facevano in piazza e la parola bello, per come la intendevano i greci, comprendeva il bene : kalòs agatòs. La piazza e la dimensione politica dell’architettura vanno all’unisono. Nella mia esperienza è sempre da lì che parto, anche quando non c’è. Io lavoro sempre per immagini e, se penso a Whitney di New York, che era un edificio all’incrocio tra, Washington Street e Gansevoort Street, lì non c’era spazio. Bisognava sollevarlo per creare spazio sotto, così è nata una piazza detta largo. Anche alla Columbia University c’è una piazza, detta piazzetta.
Anche il Beaubourg a Parigi ha davanti una grande piazza.
Sì, una piazza che in qualche maniera è una riproduzione di piazza di Spagna. Erano stati presentati 651 progetti per il museo voluto da Pompidou e noi siamo stati gli unici, talmente pazzi, a non utilizzare nel progetto tutta l’area prevista, ma di usarne solo la metà, elevando del doppio l’edificio. Abbiamo regalato così l’altra metà alla città creando un vuoto, una piazza. Il bello del vuoto, nella città, è che è destinato subito a riempirsi di energie. Infatti, se guardi alla storia delle civiltà, è sempre andata così, nell’antica Roma ma anche in una città come Beirut, dove c’è una piazza che si chiama Martyrs’ Square, dove avvengono tutte le attività civiche, di incontro, di festa o di protesta. La piazza è un luogo magico dove si incrociano le esperienze, le età. Dove persino la paura viene dissipata dallo stare insieme. La piazza e forse anche i ponti che attraversano i fiumi, insieme ai lungo fiumi, ai giardini, ai parchi, sono le icone che rendono bella e vivibile una città.
Il ponte è una metafora potente e ci sono tue costruzioni che somigliano a ponti.
Il ponte è fisico, ma anche metaforico naturalmente. Per questo i ponti non possono e non devono crollare ! Tu prima mi hai domandato in che misura l’architettura è politica. È politica perché è l’arte della polis. Il costruire la città resta una grande conquista perché la città è un’invenzione straordinaria dell’uomo. Non esiste in natura. La città è nell’immaginario di tutti, c’è anche nelle sacre scritture. Non è che io sia un grande specialista, ma nella Bibbia si parla della città verso cui l’umanità cammina. Il destino dell’uomo è la città perché l’antitesi della città non è la campagna, che è necessaria e fertile. L’antitesi della città è il deserto, è lì che si creano mostri. Anche nelle città nascono mostri, ma Trump non è stato eletto nelle città. A Manhattan è stato votato dal 4% della popolazione. In tutta New York dal 10%. L’islam che fa paura non è quello dei porti e dei fiumi, delle città incasinate fin che vuoi, ma vitali. È piuttosto del deserto. Sempre nelle sacre scritture si parla di una città ideale estesa per 12.000 stadi, cioè 2.500 chilometri per 2.500 chilometri. Se tu disegni quel quadrato ci metti dentro tutta l’Europa e, se ci pensi bene, l’Europa non è che un’unica grande città ricca di campagne, di foreste, di laghi, ma senza deserti. È un continente in cui tutto è antropizzato e questa è la città : la più grande scommessa dell’uomo. Per questo, quando una città è malata, non bisogna ucciderla, bisogna curarla. Gli attentatori delle torri gemelle che hanno colpito la città volevano dirci nascondetevi nei bunker, questo è il vostro destino.
Tu hai reagito a quell’attentato costruendo la nuova sede del New York Times, rivendicando il diritto alla trasparenza, all’apertura.
Dopo l’11 settembre del 2001 per un anno a New York il problema era che non si dovevano più costruire edifici alti e c’era un gran dibattito su come proteggersi. Io stavo progettando la nuova sede del New York Times e, grazie a dei buoni clienti come erano gli Ochs-Sulzberger, abbiamo deciso che la trasparenza del piano terra era ben più sicura dell’opacità. La trasparenza porta con sé la sicurezza. Tu vedi, non ti nascondi. Naturalmente io ne ho approfittato subito perché la trasparenza non è solo sicura, è anche urbana, partecipativa, è l’idea di una città nella quale c’è dialogo tra gli edifici e la strada, ed è un dialogo di convivenza, non di possesso.
Tu dici che l’architettura non produce cambiamenti, ma dà forma ai cambiamenti.
Sarebbe un pochettino esagerato pensare che un architetto cambi il mondo. Come sai meglio di me, il mondo cambia di suo e molto spesso con strappi anche abbastanza indigesti, non sempre positivi. L’architettura, come la letteratura e il cinema, in qualche maniera è specchio della società e traduce in forma costruita il cambiamento, lo celebra. Qualche volta lo fa in maniera retorica e accademica, o addirittura cretina, stupida. Ma se riesce a farlo in maniera autentica, beh, non è male. A me è capitato con il Beaubourg. Non fu un edificio che cambiò il corso del rapporto tra l’arte e la città, ma in qualche maniera celebrò il cambiamento che stava avvenendo.
C’era stato il maggio ‘68 tre anni prima, io abitavo nella Londra dei capelli lunghi e delle gonne corte, nella Londra dei Beatles, e qualcuno doveva assumersi l’onere e lo sporco lavoro di trasformare questa ribellione alla cultura di élite, riservata agli specialisti, in qualcosa di costruito. Ci capitò di farlo nella maniera più estrema : costruimmo una enorme macchina, una fabbrica atterrata nel centro di Parigi. Lo stesso mi è capitato di fare a Berlino dopo la caduta del muro, a San Francisco con l’Academy of science, che è il primo edificio pubblico che non ha bisogno di aria condizionata perché protetto da un tetto ondulato vegetale.
Questo vale anche per le università. In America le università si costruivano imitando il linguaggio dell’antica Grecia, dell’antica Roma. Lo stile neoclassico o gotico voleva dire : fidati di me perché sono antica. Ma io dico ai nostri amici americani che è tempo di smetterla, perché in fondo questo paese ha una sua storia. E mentre 150 anni fa l’università aveva una forma conchiusa, io penso che adesso bisogna dargli una forma inclusiva, devi aprirla alla strada. Devi fare in maniera che ci sia permeabilità, soprattutto se costruisci un nuovo campus a West Harlem, nella periferia nord di Manhattan, che è sempre stata teatro di una cultura di strada in tutti i sensi.
Un altro esempio è l’ospedale che stiamo costruendo in Africa con Gino Strada. Dobbiamo guardare all’Africa non solo come luogo di sofferenza e di tragedia, ma anche come teatro di energia. Se smettiamo di farla a pezzi, l’Africa è il continente del futuro. Non sei certo tu a cambiare, ma se pensi che l’Africa può rinascere, in qualche modo celebri questa trasformazione, in questo caso con Emergency, che porta l’eccellenza medica e pediatrica nel cuore dell’Uganda.
Ascolta, nel 2017 sono arrivati un Uganda un milione e mezzo di migranti dal Sudan meridionale, che è un paese poverissimo. Sai cosa hanno fatto gli Ugandesi ? Hanno assegnato a ogni famiglia emigrata un terreno di 10 metri per 10 con l’accesso a una pompa d’acqua, sufficiente per coltivare piante che diano da mangiare. Noi, al contrario, pensiamo che costituiscano un problema insormontabile poche centinaia di migliaia i migranti giunti dall’Africa in Europa, che è un continente ricchissimo. L’architetto, come l’educatore, il giornalista, lo storico e il cineasta, assiste a questi cambiamenti e li interpreta. Se c’è un contenuto possente, come costruire un ospedale di eccellenza in Uganda, questo nobilita l’architettura.
Tu spesso critichi gli stili, l’accademia.
È vero, ed è per ragioni personali, perché io sono stato considerato in questo paese, per un po’ di anni, come una specie di tecnologo e forse non era neppure sbagliato, perché mi divertiva l’idea di costruire mettendo insieme dei pezzi. Ma è stato soltanto andando via dall’Italia che sono stato riconosciuto come uno che usava sì la tecnologia per costruire, ma costruiva luoghi per la gente, santo cielo. A te non importa niente della tecnica educativa, ti interessa se funziona con i bambini. A me non interessa niente tenere assieme dei pezzi, voglio sapere per farne cosa : per una fabbrica d’armi o per un museo, un ospedale, un luogo dove la gente si trova insieme. In un iceberg, la parte che emerge è solo un decimo, ma sono i nove decimi che tu non vedi che lo tengono su. Di questo stiamo parlando. Dei contenuti spesso nascosti che reggono tutto.
Da oltre dieci anni più della metà della popolazione del pianeta vive nelle città. Il problema è che la maggioranza abita in periferie brutte, invivibili, spesso infernali. E questo è uno dei grandi problemi che sta all’origine delle tante difficoltà nella convivenza.
Il nuovo tribunale di Parigi lo abbiamo finito sei mesi fa a Saint-Denis, alle porte di Parigi, in una delle banlieue più difficili. Diecimila persone al giorno abiteranno quell’edificio : magistrati, avvocati, convocati. Molti cercheranno di abitare lì vicino. Ecco che tu porti nella banlieue qualcosa che la feconda, la fertilizza. È un tribunale, naturalmente, e tu ci devi portare anche le università, come stiamo facendo nella banlieue sud. E poi devi cercare di fare quel rammendo di cui qui al G124 parliamo sempre.
In Italia, se pensiamo al serpentone di Corviale a Roma, alle vele di Scampia o allo Zen 2 di Palermo, siamo di fronte a idee innovative di architetti impegnati e di sinistra, che nel corso della costruzione si sono trasformate e nel loro uso si sono rovesciate nel loro esatto contrario. Goffredo Fofi sostiene che bisognerebbe condannare certi architetti a vivere nei palazzi che hanno progettato. Perché molte periferie sono così brutte e invivibili ? L’urbanistica, in Italia, mi sembra sempre più incapace di immaginare e progettare cambiamenti significativi nelle periferie.
Gli architetti hanno fatto errori, è vero, talvolta per eccesso di utopia. Forse non c’è stato sufficiente dialogo con quelle realtà. Ci sono stati anche architetti come Giancarlo De Carlo, che hanno cercato di capire meglio, hanno cercato maggiore dialogo. Ma il vero problema delle periferie non riguarda quei tre o quattro palazzi che hai nominato. Il problema è che il 99 per cento delle periferie sono state costruite senza amore, senza affetto. Sono state costruite poveramente, per i poveri, pensando solo all’interesse e al guadagno, per lo più dagli immobiliaristi. Tutti sanno che una città come Roma è stata costruita con un sistema di crescita a macchie, come alopecia. Ci sono stati anche interventi pubblici, ma è mancato quasi sempre l’amore per ciò che si progettava.
Però, in passato, sono stati costruiti quartieri come la Garbatella, che aveva una sua estetica.
È vero, lì c’era un certo ordine, un’armonia. A Milano, ad esempio, lo scorso anno abbiamo lavorato con il gruppo dei ragazzi del G124 al Giambellino, quartiere costruito negli anni ’30, per richiamare in Italia quelli che erano andati a lavorare in Abissinia, in Africa. È stato costruito con una certa garbatezza e dignità. Ogni tanto ci sono dei segni che mostrano un po’ più di affetto, e allora qualcosa in più c’è.
Le periferie costituiscono una grande sfida anche per noi educatori. Cosa si può fare ?
Il problema non riguarda solo gli architetti e va affrontato politicamente, nel senso più ampio della parola. Io mi limito a dire una cosa : le periferie non sono così disperate perché intanto godono spesso di un po’ più di spazio e la natura può essere un buon elemento di ricucitura perché porta sempre bellezza. Certo, quando hai casermoni alti costruiti a poca distanza, tu mi dirai la natura un piffero, ma ci sono tentativi per trasformarli, non per forza si devono demolire. A Milano, a Ponte Lambro, ci sono due stecche lunghe 500 metri, che abbiamo parzialmente corroso per portarci dentro residenze per giovani e lavoratori. Il problema, infatti, è che dobbiamo uscire dalla monofunzionalità e accedere alla plurifunzionalità. Poi ci vuole un mix generazionale, perché non ci possono essere quartieri abitati solo da persone anziane. Se tu li apri a studenti o a giovani che non hanno tanti mezzi, introduci differenze vitali.
Le insegnanti e gli insegnanti più accorti sanno che la disomogeneità è vitale, quando la si affronta con impegno e ci si lavora con cura.
Certo, la disomogeneità e le diversità aiutano. È proprio dell’urbanitas, dell’urbanità che tanto ci piace, un senso di appartenenza aperto alla sorpresa. E questa è possibile nella città quando si mescolano diverse funzioni : quella residenziale e quella commerciale dei negozi, non degli shopping center, che devono potersi intrecciare con funzioni produttive e amministrative, con uffici, artigianato, cultura, scuole, servizi. Quando hai questa miscela la città vive 24 ore su 24 e non si svuota mai.
Quando si supera la monofunzionalità si realizza un miracolo. Ti giuro, Franco, può sembrarti il discorso di un pazzo, ma se con i ragazzi che sono qui al G124 avessimo la possibilità di prendere in mano una periferia e potessimo lavorarci come diciamo noi, anche senza grandi mezzi, ci metteremo dieci, dodici anni, cominciando a lavorare con i bambini che oggi hanno 8 anni, 10 anni, ma a qualcosa potremo arrivare.
Se ci mettiamo lì a primavera io, te e qualche ragazzo e piantiamo alberi alti un metro che paghiamo 10 euro l’uno, ti assicuro che tra 10 anni sono alberi da bosco.
Il problema è che dobbiamo affrontare contemporaneamente tante cose e lavorare in parallelo. Non è che prima fai la città buona e poi fai l’architettura bella, perché anche la bellezza dell’architettura aiuta, se parla di dignità. La bellezza non è una parola brutta, non è una parola frivola. È una parola importante, se l’associ al concetto di qualità. Tante cose devono andare insieme perché il meglio nasce da questa miscela, da questa mescolanza che è anche etnica, naturalmente.
Io so come dovremmo fare. Non per presunzione, ma perché ho lavorato in tante parti del mondo con tanta gente : con educatori, scienziati, poeti, artisti, e con politici. Se si mettono insieme tutti questi approcci in parallelo, non uno dopo l’altro, non è impossibile. Certo, contro la criminalità ci vuole anche l’ordine pubblico, ma non è impossibile cambiare. E poi dove vivono i giovani ? La forza delle città sta nelle periferie, dove abita il 90% dei cittadini. Le periferie sono fabbriche di desideri. Non ci sono le banche, non c’è il potere, ma lì c’è la forza e l’energia vera, quella delle speranze, del futuro. Del resto anche i centri storici sono malati. Negli anni ’60 e ’70 c’è stata una battaglia per preservare i centri storici, che è riuscita. Peccato che li abbiamo preservati fin troppo e adesso sono diventati dei musei, anzi, peggio, dei musei trasformati in shopping-street. Ora si sta cercando di reagire. Il sindaco di Londra e la sindaca di Parigi sono due persone che si danno da fare come pazzi, e anche a New York si sta lavorando per cercare di imporre anche nei centri delle città un mix che inverta la tendenza.
Come ti stai trovando a progettare per la prima volta una scuola per bambini e ragazzi.
Tu sei testimone di questo. Forse non ti ricordi, ma io lessi un tuo articolo in cui scrivevi “cari architetti, aiutateci a trasformare le scuole” e ti ho telefonato. Io avevo delle idee, ma anche il bisogno di scavare, di approfondire. La scuola che stiamo cercando di realizzare a Sora, per prima cosa ha tutte le trasparenze di cui abbiamo parlato. C’è poi una transumanza tra gli spazi chiusi e spazi aperti, liberi, dove i bambini, come tu insisti sempre, devono poter razzolare nella terra. E poi la luce, che è importante perché è nella luce dell’infanzia che si vive tutta la vita. Quando parlo di luce, non parlo solo di luce metaforica, ma di quella reale e tu, infatti, preferisci lavorare con i bambini all’aperto, dove c’è luce piena. Ci sono poi tanti altri elementi che toccano aspetti fisici, tattili, materiali. I suoni e le trasparenze sono cose da architetti, ma poi c’è la convivialità, il rapporto con la città e con le famiglie, che è fondamentale.
Se c’è un posto al mondo dove tutti vanno questo è la scuola. E in una zona sismica deve essere sicura perché, se c’è un terremoto, la prima cosa che pensi è dove sono i tuoi figli e corri lì. La scuola deve essere un luogo sicuro in tutti i sensi, anche metaforicamente, perché è il luogo dove si costruisce il futuro dell’umanità. C’è poi l’idea che il piano terra deve essere aperto e contaminato, in senso buono, dalla città. C’è il primo piano riservato alla ricerca e allo studio, e poi la terrazza, il tetto, sul quale ci siamo trovati da subito. Io adoro il tetto, le terrazze. Nei miei ricordi d’infanzia ricordo che passavo molto tempo sui tetti.
Racconti spesso che le gru di Genova hanno ispirato la leggerezza di tanti tuoi progetti.
I tetti, come ti dicevo, sono straordinari. A Genova da lì vedi il mare e il porto, che è un luogo di instabilità e leggerezza. Ci sono tutte cose che volano sulle gru e non toccano terra. Ricordi Maggiani, nella regina disadorna, che faceva volare gli elefanti… Anche le navi volano. Non volano in realtà, galleggiano, ma è la stessa cosa : non toccano terra. In qualche modo tutte quelle immagini della mia infanzia sono poi venute fuori nei miei progetti.
L’intervista è apparsa sulla MCE Rivista Pedagogica e culturale - Febbraio 2019