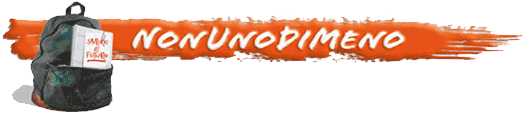Ogni anno, alle 8.10 dell’otto agosto, la campana dell’”église de Saint Antoine de Padoue”, di Charleroi, in Belgio, fa sentire i i suoi dolenti rintocchi. Campana a morto per duecentosessantadue minatori, morti asfissiati, tra il livello 975 e il livello 1035 ( più di un kilometro sottoterra), della miniera di carbone "Bois du Cazier" di Marcinelle, la mattina dell’8 agosto 1956, lasciando 212 vedove e 417 orfani.
Gli ultimi cadaveri, in condizioni pessime e difficili da riconoscere, furono portati fuori dalla miniera soltanto nel marzo del 1957.
Centotrentasei italiani, novantacinque belgi, otto polacchi, sei greci, cinque tedeschi, tre ungheresi, tre algerini, due francesi, due sovietici, un britannico e un olandese.
Un elenco di morti, suddivisi per nazionalità, non tanto perché questa sia importante, di fronte a certe tragedie, ma per capire il fenomeno migratorio in Europa e lo sfruttamento della forza lavoro che coinvolse l’Italia, dalla seconda metà degli anni quaranta agli anni settanta.
Seppure in una forma tragica, l’emigrazione per il lavoro aveva anticipato, lungo gli stretti, asfissianti e mortali cunicoli delle vene carbonifere del sottosuolo belga, la formazione della futura Europa.
Ogni anno, l’otto agosto, racconto, la singolare e poco conosciuta storia, di un accordo ufficiale tra il governo italiano e quello belga.
Sembra una storia simile a tante altre, con le navi stracariche di migranti in partenza dai porti di Genova e Napoli verso il continente americano e la quarantena di Ellis Island.
Anna Morelli, storica belga di origine italiana, definì la emigrazione italiana in Belgio, come una “deportazione” vera e propria, che obbligava quelli che decidevano di partire per sfuggire alla miseria e alla disoccupazione a scendere nel sottosuolo per almeno cinque anni, pena la detenzione.
Decine di migliaia di nostri connazionali, in partenza dalla Stazione Centrale di Milano, dopo una visita medica sommaria, spediti tramite " convogli, ammassati in treni sigillati ”a consumare la loro gioventù nelle miniere di carbone belghe.
All’ingresso del mio paese natio, Roccascalegna, nella media valle del Sangro Aventino, in Abruzzo, c’è un monumento ... costituito da un carrello pieno di carbone e una lapide, dono del Comune di Charleroi, che ricorda il sacrificio dei sei minatori roccolani morti nel pozzo di Marcinelle : Eligio e Violante Di Donato, Antonio e Nicola Di Pomponio, Giuseppe Travaglini e Mario Zinni. Quella tragedia, in una comunità che in Belgio aveva tanti altri suoi figli ha segnato in modo drammatico la mia adolescenza, anche se ho vissuto anch’io l’esperienza di migrante in Svizzera e una strage avrebbe poi segnato in modo più duraturo e profondo la mia vita.
Per questo continuo a testimoniare e raccontare. Nella speranza che le nuove generazioni e le classi dirigenti capiscano, che non c’è giustizia senza verità e che i migranti non sono carne da macello ma persone spesso costrette ad abbandonare i paesi di origine e i propri affetti per cercare altrove migliori condizioni di vita per sè e per le proprie famiglie e che, se hanno doveri verso il paese che li accoglie, hanno anche diritti, a partire da quelli universali dell’uomo e dal rispetto della dignità della persona.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Belgio è uno dei principali paesi esportatori di risorse minerarie d’Europa, ma è carente di manodopera. In realtà la manodopera c’è, ma i belgi si rifiutano di lavorare nelle miniere, lavoro che giudicano pesante e mal retribuito, a cui fino a quel momento erano stati destinati i prigionieri di guerra.
L’Italia, invece, ha milioni di disoccupati ed un’impellente necessità di carbone per far funzionare, insieme all’energia idroelettrica, l’industria metallurgica e siderurgica, quasi tutta concentrata nelle regioni settentrionali, le maggiori nel Nord Milano, che sarebbe diventato il mio futuro luogo di vita.
A fronte del trasferimento di 50.000 operai italiani nelle miniere del Belgio, in cambio Bruxelles si impegnò a fornire al nostro Paese il carbone a basso costo . Ogni mese, almeno 2.500 tonnellate di carbone per ogni 1.000 operai inviati. Risorsa indispensabile per far funzionare gli altiforni e fornire all’industria meccanica e manufatturiera le risorse necessarie per la lavorazione dei propri prodotti.
Si stabiliva, inoltre, in quell’accordo, che tutte le somme versate dagli operai italiani a qualsiasi titolo sarebbero state accreditate su un conto speciale, non generatore di interessi, intestato all’Ufficio Italiano dei Cambi, aperto presso la Banca Nazionale Belga, intitolato : "Conto Operai Italiani" ; il conto sarebbe servito principalmente per i versamenti che l’Italia avrebbe dovuto effettuare per pagare al Belgio il carbone. Queste furono le condizioni che portarono all’intesa tra Alcide De Gasperi e il Primo Ministro belga, Van Hacker, del 23 giugno 1946, che segnò l’inizio dell’emigrazione massiccia degli italiani nelle miniere belghe.
Dopo la prima Conferenza, dal 17 aprile al 20 giugno 1946, e il protocollo del 30 aprile 1948, il 1° aprile 1952, altri protocolli si sarebbero aggiunti, grazie all’istituzione, il 18 aprile 1951, della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) che facilitava la circolazione di manodopera tra i paesi ad essa aderenti, Solo dopo la sospensione dei flussi migratori susseguente alla sciagura di Marcinelle, la firma del quarto Protocollo d’intesa dell’11 dicembre 1957, tardivamente, subordinava la riapertura delle migrazioni verso il Belgio alla :
![]() partecipazione dei personale italiano alla sicurezza nelle miniere ;
partecipazione dei personale italiano alla sicurezza nelle miniere ;
![]() convalida degli anni di lavoro ai fini della sicurezza sociale anche in giacimenti italiani ;
convalida degli anni di lavoro ai fini della sicurezza sociale anche in giacimenti italiani ;
![]() estensione dei benefici della sicurezza sociale belga anche per le famiglie rimaste in Italia.
estensione dei benefici della sicurezza sociale belga anche per le famiglie rimaste in Italia.
L’11 luglio 1966 il quinto accordo di emigrazione italo-belga introduceva normative e disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione, di condizioni lavorative e di uguaglianza di trattamento dei lavoratori all’interno della Comunità.
Le varie inchieste sull’incidente, come al solito, non stabilirono responsabilità ; nel 1959 i dirigenti della miniera vennero assolti dalle accuse di inadempienza.
Nel 1961 fu poi condannato in appello a sei mesi Adolphe Cilicis, un ingegnere che dirigeva i lavori della miniera. Nel 1957 ripresero le attività della miniera che fu poi chiusa nel 1967.
Marcinelle fu il più grave dei dodici incidenti minerari verificatisi tra il 1950 e il 1956 in Belgio.
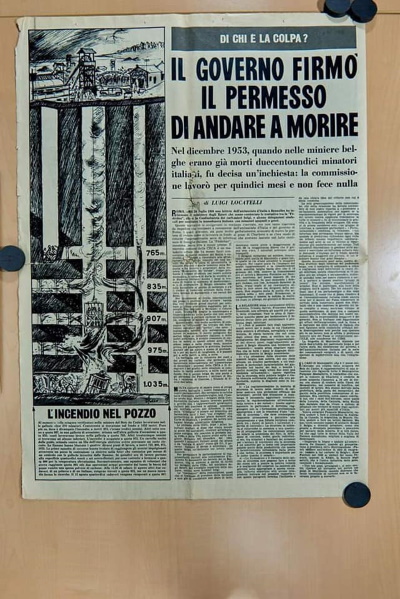 Incidenti che produssero centinaia di morti, scioperi, per tutelare i lavoratori, crisi diplomatiche. Il 24 ottobre del 1953, tre anni prima di Marcinelle, il governo italiano sospese temporaneamente le partenze verso il Belgio, per le disumane condizioni di lavoro dei minatori. Nonostante tutto, gli emigrati italiani in Belgio, trattati come carne da macello, sfruttati, perseguitati, discriminati, sottoposti a episodi di razzismo, si integrarono, studiarono e impararono la lingua, cosa dimostrata dalla massiccia presenza di italo-belgi anche tra le fila della loro classe dirigente.
Incidenti che produssero centinaia di morti, scioperi, per tutelare i lavoratori, crisi diplomatiche. Il 24 ottobre del 1953, tre anni prima di Marcinelle, il governo italiano sospese temporaneamente le partenze verso il Belgio, per le disumane condizioni di lavoro dei minatori. Nonostante tutto, gli emigrati italiani in Belgio, trattati come carne da macello, sfruttati, perseguitati, discriminati, sottoposti a episodi di razzismo, si integrarono, studiarono e impararono la lingua, cosa dimostrata dalla massiccia presenza di italo-belgi anche tra le fila della loro classe dirigente.
Dalla fine degli anni sessanta, gli impianti minerari sono stati progressivamente dismessi. Molti siti sono stati tramutati in Poli di Archeologia Industriale e sono diventati luoghi di forte integrazione, sia sociale che storica. Oggi sono vere e proprie eredità storiche, luoghi urbani che testimoniano memorie collettive.
In occasione della cerimonia per ricordare il trentesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, i belgi insorsero con indignazione alla proposta di distruggere i locali della miniera per la realizzazione di un progetto di speculazione edilizia. La mobilitazione spontanea bloccò la distruzione dell’impianto industriale.
Nel 1990, l’intero territorio della miniera fu protetto dalla regione Vallonia come sito di interesse storico.
Il 12 marzo del 2002 fu inaugurata la prima parte del museo, oggi completamente realizzato. Unico museo in Belgio ad avere come finalità principale l’intento di testimoniare il contributo fornito dall’immigrazione italiana alla crescita e allo sviluppo vallone e fiammingo.
L’"Accordo minatore-carbone" consentì all’Italia del boom economico di ottenere la materia energetica primaria, vale a dire il carbone, non solo a un prezzo favorevole, ma a condizioni di fornitura garantita da uno dei paesi più forniti di quella preziosa materia prima.
Le fabbriche del Nord riuscirono a sostenere lo sforzo di ricostruzione del paese e di rilancio della nostra economia grazie al sacrificio di migliaia e migliaia di connazionali che sacrificarono in molti casi la loro vita e, nella stragrande maggioranza, contrassero nelle miniere del Belgio malattie respiratorie che fecero fatica a farsi riconoscere come "professionali".
La natura di malattia professionale della silicosi fu, di fatto, grazie ad una legge approvata dal Parlamento Italiano nel 1962, riconosciuta l’anno dopo anche dal governo belga.
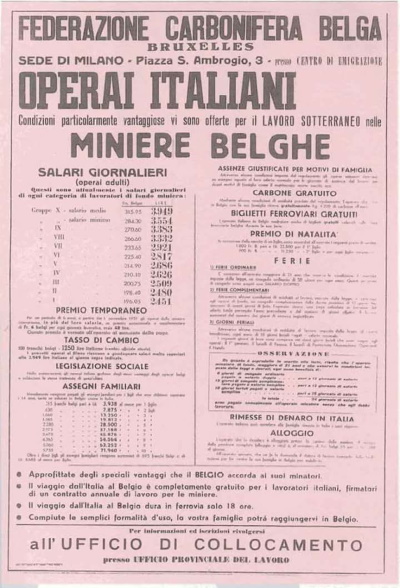 I duemila operai a settimana e i cinquantamila in totale erano destinati ad aumentare perché dall’Italia arrivarono fin da subito anche le famiglie dei minatori, mogli, figli, genitori.
I duemila operai a settimana e i cinquantamila in totale erano destinati ad aumentare perché dall’Italia arrivarono fin da subito anche le famiglie dei minatori, mogli, figli, genitori.
Nelle città e nei paesi iniziarono a comparire i manifesti rosa di “reclutamento”, (nella foto) che promettevano lavoro , buon salario e ferie pagate. In un’Italia che doveva ancora rialzarsi appariva come un insperato Eldorado.
In realtà sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro non c’era una riga. Unico requisito richiesto, una buona salute e un’età massima di trentacinque anni poi portata a quaranta. Nessuna preparazione era richiesta. Molti sarebbero scesi in miniera per la prima volta in Belgio.
Cantine, baracche di legno e lamiera, ex campi di prigionia. Erano queste in una prima fase le abitazioni dei minatori italiani, gli alloggi “convenienti” citati nel protocollo italo-belga. Le cantine erano dormitori comuni, con letti a castello, mentre le famiglie vivevano nelle baracche. I bagni e le fontane per l’acqua erano esterni e in comune, in un Paese dalle temperature non certo accoglienti.
Il “Sole d’Italia”, giornale delle Acli e del Sindacato Cristiano Belga, pubblicò un’inchiesta in cui denunciava l’“impressionante desolazione, povertà estrema” in cui vivevano i nostri connazionali. “Lunghe baracche di colore verde-sporco, ricoperte di carta catramata, impressione di campo abbandonato dagli ex prigionieri”. Solo alla fine del 1948 nelle miniere lavoravano quasi settantasettemila italiani".
Post di Fortunato Zinni 08 agosto 2021